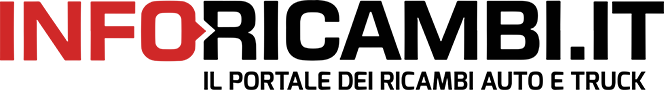L’efficienza dei moderni propulsori a benzina non è dovuta soltanto al downsizing: i motori che adottano il ciclo Miller possiedono infatti un’architettura termodinamica capace di limitare i consumi fin dalla radice del processo di combustione.
Nei classici motori a ciclo Otto la fase di compressione e quella di espansione coincidono in lunghezza perché determinate dal medesimo braccio di manovella dell’albero motore. Il risultato è un equilibrio che, per quanto collaudato, spreca parte dell’energia presente nei gas di scarico, la stessa che, negli impianti turbocompressi, mette in rotazione turbine da diversi kilowatt. L’ingegnoso James Atkinson ideò nel 1882 un ciclo capace di sfruttare meglio tale energia: prolungando l’espansione oltre la compressione, i gas cedono più calore e pressione trasformandosi in lavoro meccanico aggiuntivo. Da quell’intuizione nacquero motori dai cinematismi complessi, poi semplificati nell’odierno ciclo Miller, che raggiunge lo stesso obiettivo abbreviando artificialmente la compressione.
Come? Con la chiusura ritardata o anticipata della valvola di aspirazione (spesso entrambe), così da ridurre la massa d’aria effettivamente compressa e abbassare il rapporto di compressione apparente. Una volta sigillata la camera, la combustione procede regolarmente, ma la fase di espansione, invariata in lunghezza, risulta ora più “lunga” rispetto alla compressione effettiva, recuperando energia che altrimenti finirebbe nello scarico.
Il motore a ciclo Miller sulle auto moderne
La compressione accorciata riduce però coppia e potenza specifica. Per rimediare, i costruttori seguono due strade: l’ibridizzazione o la sovralimentazione. Toyota, pioniera delle ibride, affianca ai propri motori Miller un’unità elettrica che colma il vuoto di coppia ai bassi regimi, ottenendo un’erogazione fluida e consumi contenuti. Volkswagen ha scelto invece la via plug-in: la nuova Passat Variant 2024 abbina un 1.5 l Miller a una batteria capiente, promettendo fino a 100 km in elettrico puro.
Anche Honda utilizza la fasatura variabile i-VTEC per ritardare selettivamente la chiusura delle valvole di aspirazione, mentre Suzuki adotta una strategia simile su diversi modelli compatti. In FCA/Stellantis il progetto Firefly impiega il ciclo Miller su alcune cilindrate, come pure fa Renault con l’ultima generazione dei sistemi ibridi E-Tech e i motori TCe. Mazda, infine, sperimentò già negli anni ’90 il 2.3 l V6 KJ-ZEM sulla berlina Millenia, dimostrando che questa filosofia non è legata a un’unica architettura.
La riduzione della compressione, oltre a limitare le emissioni, mitiga il fenomeno del battito in testa e le autoaccensioni indesiderate, permettendo di spingersi verso rapporti di espansione elevati senza compromettere l’affidabilità. Quando la perdita di coppia non viene compensata da un motore elettrico, interviene la sovralimentazione: compressori e turbine ristabiliscono la densità di carica in ingresso, sposandosi perfettamente con la maggiore efficienza termodinamica del ciclo Miller.
Grazie a queste soluzioni, il ciclo ideato da Atkinson e perfezionato da Miller è tornato protagonista nella mobilità contemporanea, offrendo ai costruttori un margine concreto per ridurre consumi ed emissioni senza rinunciare a prestazioni e guidabilità.