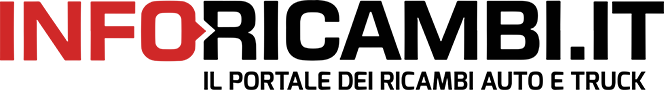Un nuovo campanello d’allarme suona nel settore automotive italiano. Secondo i dati emersi dall’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana, condotto da ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, il 12% delle aziende dell’indotto automotive sta valutando l’idea di cambiare settore.
Questo dato, risultato di un’analisi approfondita sulle condizioni di mercato e sulle prospettive future, porta alla luce preoccupazioni che si sono intensificate a causa della crescente incertezza economica e della transizione verso la mobilità sostenibile. Il 2024 per il settore è stato infatti un anno di regressione con il 55% delle aziende che ha dichiarato di aver diminuito il proprio fatturato. Inoltre per un’impresa su tre è prevista una contrazione dell’occupazione. Una situazione che è ancor più preoccupante alla luce del taglio di 4,6 miliardi di euro al fondo automotive da parte del Governo.
L’Osservatorio segnala che una parte significativa delle aziende manifatturiere, in particolare quelle di medie e piccole dimensioni, fatica a stare al passo con le nuove normative e i cambiamenti di mercato. Per queste realtà, la strada della diversificazione o del cambio di settore è sempre più vista come una via di fuga rispetto a una transizione che sembra penalizzare chi non ha sufficienti risorse da investire.
Automotive, una svolta epocale
Di fronte a un quadro che potrebbe vedere la perdita di molte aziende specializzate nella componentistica, gli esperti del settore chiedono a gran voce una “cabina di regia” ministeriale.
Questo organismo coordinato dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo i promotori, dovrebbe avere il compito di supportare il settore e fornire orientamenti chiari. Un’azione di coordinamento potrebbe aiutare le aziende dell’indotto a intercettare meglio le opportunità del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e ad adattarsi al Green Deal europeo, ottenendo accesso a fondi e strumenti per la riconversione o la diversificazione produttiva.
Secondo il Presidente di ANFIA, infatti, una cabina di regia potrebbe servire come piattaforma per la collaborazione tra pubblico e privato, garantendo che le politiche industriali rispondano alle necessità dell’intera filiera e non solo dei principali produttori. La richiesta è supportata anche dalle associazioni di categoria e dagli operatori del settore, che sottolineano come una visione strategica condivisa possa evitare la perdita di competenze e posti di lavoro.
Con l’industria automotive globale che punta sulla mobilità elettrica e a idrogeno, gli investimenti in queste nuove tecnologie continuano a crescere, e i produttori sono sempre più orientati verso modelli di business sostenibili. Tuttavia, non tutte le imprese dell’indotto italiano riescono a trasformarsi con la stessa velocità. Le difficoltà incontrate da queste aziende rischiano di rallentare la transizione di tutta la filiera, con ripercussioni non solo sul piano economico ma anche su quello occupazionale.
Secondo l’Osservatorio ANFIA, i segmenti più a rischio sono quelli legati alla componentistica meccanica tradizionale, come la produzione di motori a combustione e trasmissioni, che diventano meno rilevanti nel passaggio all’elettrico.
Questo fenomeno mette in discussione la sopravvivenza di una parte dell’industria, spesso costituita da imprese familiari che rappresentano la spina dorsale di interi distretti industriali. Il settore della componentistica automotive impiega circa 280.000 persone in Italia. Una transizione non adeguatamente accompagnata da politiche mirate rischia di generare un impatto pesante sull’occupazione, soprattutto nelle aree maggiormente industrializzate come Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia.
La mancanza di una guida strategica potrebbe portare a una perdita massiccia di posti di lavoro e competenze, colpendo duramente il sistema economico italiano. Un cambio di settore per il 12% delle imprese significherebbe inoltre una fuga di professionalità preziose, il che aumenterebbe la difficoltà di colmare il gap tecnologico nel settore della mobilità sostenibile. Questo processo potrebbe lasciare un vuoto difficile da riempire, specialmente in una fase di mercato in cui la domanda di competenze digitali e tecnologiche è sempre più alta.